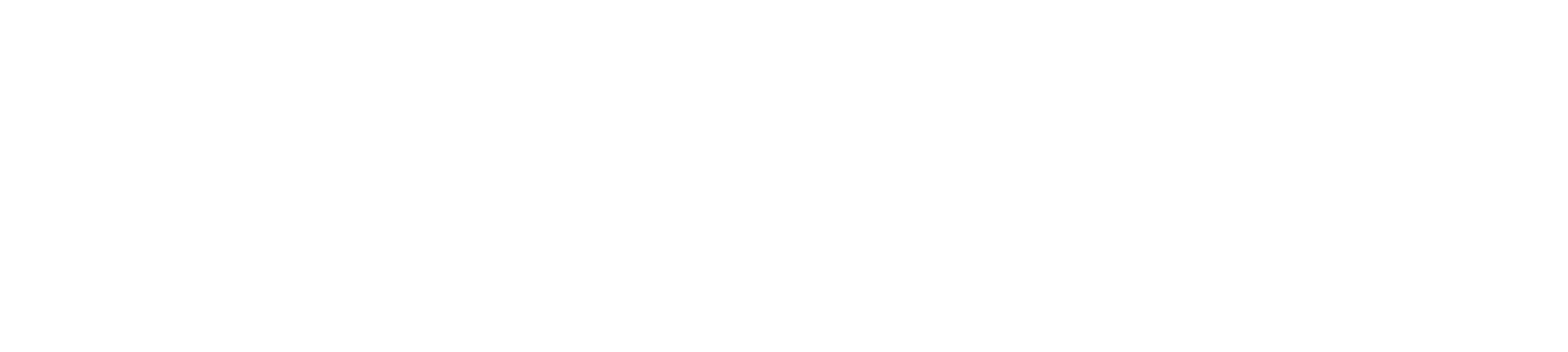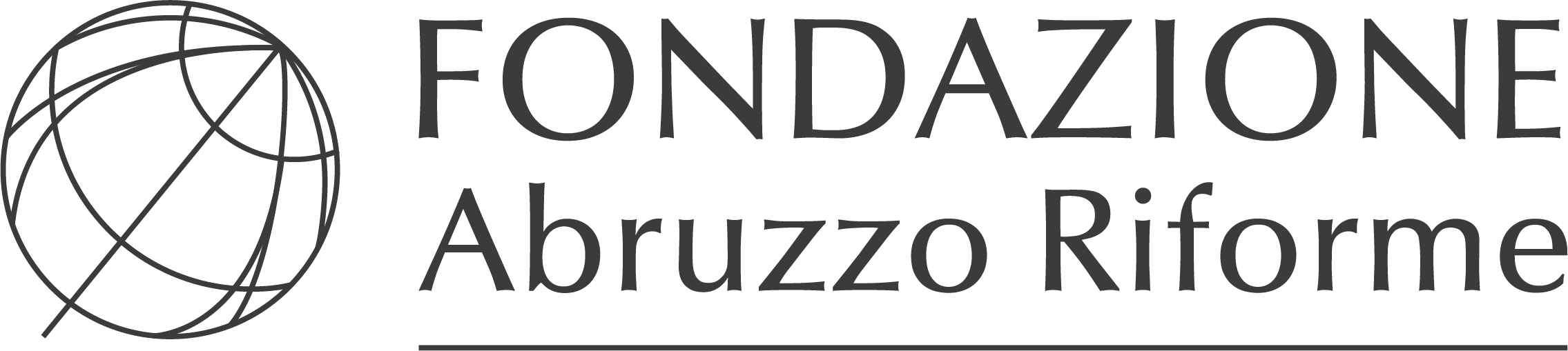Si va verso la celebrazione del Primo Maggio ed è facile prevedere che anche quest’anno torneranno a riecheggiare discorsi e polemiche che si sentono ormai da molto tempo. Qualcuno si chiederà se oggi ha ancora senso una Festa del Lavoro. E molti altri sosterranno che solo quelli che hanno un lavoro possono permettersi di festeggiare il Primo Maggio mentre tutti gli altri non hanno nulla da festeggiare. E così via, come accade ormai da decenni.
La lunga storia di una festa di lotta
In larga parte, queste polemiche sono frutto di una scarsa conoscenza delle stesse ragioni del Primo Maggio, originariamente legato alla richiesta di una giornata lavorativa di otto ore. Si trattava quindi di una richiesta di giustizia sociale, legata all’ambito del lavoro negli anni in cui esso si stava profondamente modificando per l’arrivo dell’industrializzazione. Attualizzandola, quella richiesta originaria potrebbe essere formulata come una domanda di equità nei trattamenti e nelle modalità di erogazione del lavoro, ad esempio con un riconoscimento dei diritti per tutti i lavori a termine, precari e similari. Ed in quella direzione, ad esempio, era andata la nascita, all’inizio del nuovo millennio, di una versione “alternativa” del Primo Maggio, l’Euro Mayday: una festa dedicata proprio ai lavori precari e irregolari, dai toni irriverenti che, a partire dal 2004, sarebbe stata aperta dalla statua di San Precario. L’irriverenza dei toni è, del resto, evidente sin dal titolo perché scrivendo MayDay tutto attaccato si evocava – ironicamente – una richiesta di aiuto per un mondo del lavoro in drammatica trasformazione.
Questa doppia caratteristica del Primo Maggio, l’essere un momento di festa e di lotta, rimanda alla stessa natura dello sciopero. Come scrivono in un libro recente sulla Storia del lavoro nell’Italia contemporanea Stefano Gallo e Fabrizio Loreto, gli scioperi sono sempre stati considerati «le vacanze del proletariato».
Soprattutto nella fase delle origini, gli operai che uscivano dalle fabbriche e i contadini che abbandonavano i campi vivevano quel gesto semplice, e allo stesso tempo dirompente, come un momento di felicità e di liberazione dalle fatiche quotidiane; per questo, durante l’astensione collettiva del lavoro si poteva assistere a riunioni all’aperto, balli, concerti, biciclettate e passeggiate, per divertirsi e rilassarsi insieme. (...) Proprio a voler sottolineare questo aspetto, ci si vestiva con “l’abito buono della festa”.
E così poteva anche capitare che per reagire ad un divieto di festeggiare e all’obbligo di andare comunque in fabbrica, gli operai di Voghera si recassero al lavoro vestiti a festa. Era il primo maggio del 1890, il primo Primo Maggio in Italia.
Sempre uguale e sempre nuova
Il Primo Maggio ha una curiosa caratteristica: è sempre uguale e sempre diverso. È per questo che è così difficile studiarlo, perché farlo significa confrontarsi non solo e non tanto con le ragioni e i valori della festa, ma anche con le declinazioni che ha assunto nel tempo e nello spazio.
Come ha scritto Francesco Renda in una bella ricostruzione della storia di questa festa di qualche anno fa, il Primo Maggio è una cosa semplice e allo stesso tempo complessa:
semplice perché ogni 1° maggio è una celebrazione di sé stesso. Complessa, perché ogni 1° maggio non è mai uguale a sé stesso, non è uguale in senso cronologico e nemmeno in senso geografico. Ogni 1° maggio, pur rimanendo 1° maggio, è sempre andato soggetto a cambiamento, come sempre cambia ogni altra cosa del mondo. Il 1° maggio ha avuto una origine unitaria e una attuazione plurale
Perché – e questa è un’altra caratteristica essenziale del Primo Maggio – la festa del lavoro è internazionale per definizione e nascita, visto che la sua origine è legata alla nascita della Seconda Internazionale nel 1889 e ai precedenti scioperi di Chicago del 1886, indetti proprio per la richiesta delle 8 ore, che finirono in scontri e che portarono alla condanna e alla uccisione dei cosiddetti “martiri di Chicago”.
Le ragioni che collocano la festa del lavoro il primo maggio, allora, sono storicamente determinate, ma hanno anche rimandi simbolici più antichi: come ricordano ancora Gallo e Loreto, esso è legato ad antichi riti propiziatori per l’arrivo della primavera ma, allo stesso tempo, affonda le sue radici nella ritualità cattolica, e in particolare, al mese di maggio come mese mariano che
tendeva a contrapporre all’esaltazione della divinità della natura il culto della Madonna, simbolo per eccellenza della fertilità femminile.
E così, in un paese profondamente cattolico come l’Italia, «i primi dirigenti del movimento operaio (...) usarono miti e simboli del passato per elaborare una nuova religione politica» facendo coincidere il Primo Maggio con la «Pasqua dei lavoratori» che
richiamava in modo esplicito sia la passione che la resurrezione di Cristo: l’immagine cioè di una sofferenza immane, seguita però dalla speranza di un futuro di rinascita, non solo individuale ma collettiva.
Una festa sempre attuale
Nonostante abbia cambiato pelle molte volte nel corso della sua storia ultracentenaria, il Primo Maggio non ha perso la sua attualità, perché è lo specchio del modo in cui una società vede e considera il lavoro.
C’è stato, infatti, una prima fase nell’Italia liberale in cui, temendo le masse organizzate dei lavoratori, il Primo Maggio era stato vietato.
Per poi, invece, essere riconosciuto e "tollerato" dal mondo borghese nel momento in cui i socialisti iniziavano ad avere un ruolo parlamentare. Risale a questi anni, ad esempio, un libro incompiuto di Edmondo De Amicis, intitolato proprio Primo maggio e pubblicato nel 1990 da Garzanti (lo trovate – scaricabile gratuitamente – qui).
Negli anni del fascismo, il Primo maggio viene abolito perché era un pericoloso simbolo aggregatore per i lavoratori di fede socialista, e viene sostituito con il più innocuo 21 aprile, festa della nascita di Roma.
Ma anche nel dopoguerra, in anni di scontro frontale fra cattolici e comunisti, Pio XII colloca la festa di San Giuseppe artigiano proprio il Primo Maggio, per non lasciare la festa del Lavoro nelle mani dei soli partiti di sinistra.
All’inizio degli anni Settanta, poi, il primo maggio diventa il luogo dell’incontro tra i sindacati confederali, momento di unità simbolica che precede quella organizzativa dell’unità sindacale.
E, infine, negli anni Novanta assume sempre più i tratti di festa, una trasformazione che sottolinea, allo stesso tempo, la crisi del lavoro in senso novecentesco e la necessità di non perdere un momento simbolico di centralità del lavoro stesso.
La sua attualità, in fin dei conti, è legata alla riflessione che innesca sul ruolo che il lavoro e la sua difesa hanno nella nostra società.
Ed è per questo che continua ancora oggi ad essere necessario.
I libri citati sono:
Francesco Renda, Storia del Primo Maggio. Dalle origini ai giorni nostri,
Ediesse, Roma 2009
Stefano Gallo e Fabrizio Loreto, Storia del lavoro nell’Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna 2023
Per EuroMayDay, vedi https://www.intangiblesearch.eu/search/show_ich_detail.php?db_name=intangible_search&lingua=italiano&idk=ICH-GIU02-0000000276# e
https://milanoinmovimento.com/movimenti/limmaginario-mayday-ventanni-dopo